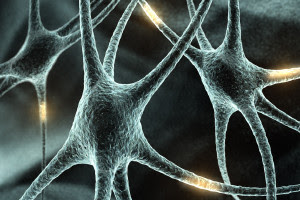Il cervello degli adulti non ha la stessa plasticità di una mente giovane. Ma ora gli scienziati del Cnr di Pisa hanno identificato un meccanismo molecolare che potrebbe restituire quella duttilità persa nel tempo. Il team dell’istituto di neuroscienze ha applicato la scoperta su cavie di laboratorio. Con risultati sorprendenti: i ricercatori italiani sono riusciti a ridare alla corteccia visiva di topi adulti la plasticità tipica di topolini giovani. Una scoperta che potrebbe avere grandi implicazioni nelle terapie riabilitative. E che sarà pubblicata domani sulla rivista Neuron.
Il cervello degli adulti non ha la stessa plasticità di una mente giovane. Ma ora gli scienziati del Cnr di Pisa hanno identificato un meccanismo molecolare che potrebbe restituire quella duttilità persa nel tempo. Il team dell’istituto di neuroscienze ha applicato la scoperta su cavie di laboratorio. Con risultati sorprendenti: i ricercatori italiani sono riusciti a ridare alla corteccia visiva di topi adulti la plasticità tipica di topolini giovani. Una scoperta che potrebbe avere grandi implicazioni nelle terapie riabilitative. E che sarà pubblicata domani sulla rivista Neuron.Gli scienziati hanno lavorato sull’ipotesi che, nei neuroni adulti, la minore plasticità del cervello - cioè la capacità di modificare le connessioni neurali in risposta agli input esterni - dipenda da una ridotta capacità di trasformare gli stimoli ambientali in risposte biochimiche. Tale funzione ha sede nella corteccia cerebrale ma è maggiore nella fase di crescita. Sembra infatti che nei cervelli giovani le stimolazioni provenienti dall’esterno lascino una traccia, a livello di trascrizione dei geni, molto più forte di quanto avvenga da adulti.
Il periodo della crescita, quando le connessioni neuronali sono più duttili, è molto delicato. Per esempio, se nei primi anni di vita un bambino si trova sottoposto a stimoli visivi non adeguati, può accadere che la sua corteccia cerebrale non si sviluppi bene e che questo causi, di conseguenza, una riduzione della vista.
Il loro obiettivo, a questo punto, era invidivuare le differenze di plasticità. I ricercatori italiani hanno così confrontato in laboratorio la corteccia visiva di topolini giovani con quella di topi adulti. Ed hanno scoperto che nei primi, gli istoni - cioè le proteine che formano l’ossatura del Dna - sono più reattivi. Inoltre, sono modificabili da stimoli esterni, come un fascio di luce. Poiché queste modifiche influenzano l’attività dei geni, il team di Pisa ha identificato in esse la causa della maggiore o minore plasticità del cervello.
Per dimostrarlo, i ricercatori hanno provato a produrre delle modificazioni sugli istoni. E per farlo, hanno usato sui topi una sostanza, la tricostatina, che aumentando l’acetilazione degli istoni, provoca le stesse reazioni generate in una giovane mente da una stimolazione luminosa. Il risultato ha confermato la teoria: nei cervelli adulti trattati con tricostatina la plasticità della corteccia visiva è aumentata e i topi adulti si sono comportati come quelli in via di sviluppo.
"Il nostro studio - ha spiegato Tommaso Pizzorusso, che ha diretto il lavoro dell’équipe di ricercatori - ha individuato un meccanismo per ripristinare negli adulti la plasticità di una mente giovane". Ma c’è di più: questo sistema potrebbe essere applicabile in generale e non solo alla corteccia visiva: "Trattamenti di questo tipo potrebbero essere usati nelle patologie dove è necessario ottenere un aumento della plasticità sinaptica per favorire l’azione di terapie riabilitative". "Ma - avverte Pizzorosso - è opportuno ricordare che le alterazioni del controllo della trascrizione del Dna non sono prive di possibili effetti negativi. Occorrerà quindi individuare bene quali strumenti utilizzare per sfruttare al meglio la nuova possibilità".
Fonte: lavocedifiore.org